©
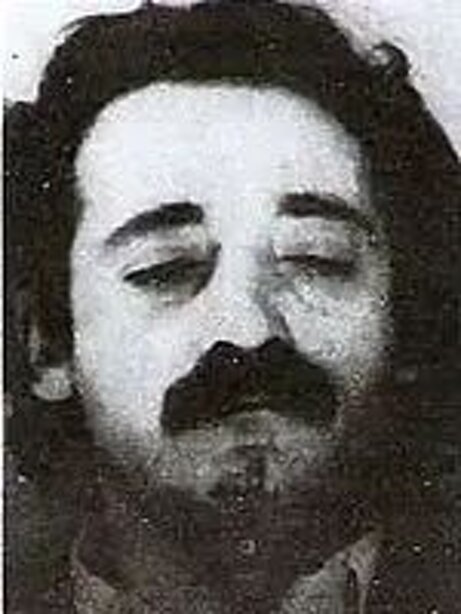
Brigate Rosse. Una storia italiana. Un intervista scritta da Carla Mosca e Rossana Rossanda. L’intervistato è Mario Moretti, il più longevo come attività brigatista di tutte le Br. Moretti milita nell’organizzazione dalla loro fondazione nel 1970 all’aprile del 1981 quando viene arrestato. In quei giorni del 1981 le Br sono a pezzi, dopo l’omicidio Moro sono isolate e divise, Moretti sta cercando di ricostruire una colonna a Milano, è con Fenzi, commette “una sbavatura che finisce in patatrac” ma “quante volte si fa una sciocchezza pur sapendo che è una sciocchezza“, in altri tempi il contatto che li fa cadere in trappola sarebbe stato scartato già al primo incontro ma questa volta Moretti finisce nelle mani della polizia grazie ad un infiltrato, Renato Longo, un ladruncolo e spacciatore che è diretto dal capo della Digos di Pavia Cera e dal capo della mobile Filippi.
Rossana Rossanda cerca in questo libro di raccontare cosa c’era alla sinistra estrema del PCI negli anni settanta, lei che insieme ad altri si è trovata schiacciata tra il PCI ed il terrorismo rosso. Come inevitabilmente anche il lettore, le giornaliste si pongono la domanda: credere o non credere a Mario Moretti? Perché questo è il vero punto nodale di questo libro. Di Moretti sappiamo che non ha mai mentito alla magistratura, non ha mai collaborato e ha sempre sostenuto di non voler rivelare fatti che potessero incriminare persone che la magistratura e la polizia non è riuscita a prendere. Quindi in questo libro Moretti tace su alcuni punti, per esempio chi era il brigatista mai individuato (il signor “Altobelli”) che viveva nell’appartamento di via Montalcini 8 dove era prigioniero Moro, e come lui stesso sia riuscito e grazie a chi a rimanere una decina di anni latitante anche se fa capire che intorno alle Br c’era una rete di persone, che non partecipavano alle azioni, che ospitavano e nascondevano i brigatisti nei momenti più duri.
Quando inizia il suo percorso da brigatista Moretti lavora alla Sit Siemens una fabbrica che produce “telefoni e brigatisti in uguale proporzione”. Circa un centinaio all’interno della fabbrica, una decina quelli che si diedero alla clandestinità. Nel 1971 partecipa alla prima rapina delle Br e alle prime azioni contro i dirigenti delle fabbriche milanesi lotte che a detta di Moretti, che cita insospettabili operai non violenti aclisti, permettevano ai lavoratori di respirare un po' di aria di libertà in fabbrica, ma la polizia è già sulle loro tracce e a via Boiardo effettua i primi arresti dove Moretti riesce a salvarsi per caso: riconosce uno dei giornalisti chiamato dalle forze dell’ordine sotto il portone di casa, Enzo Tortora con la sua troupe. Qui inizia la clandestinità di Moretti che abbandona oltre che la macchina dove è appoggiato Tortora per prendere appunti, anche sua moglie Lia e suo figlio Marcello, e conseguentemente tutta la sua famiglia, in dieci anni di clandestinità Moretti non li rivedrà mai, “come un fantasma passa attraverso i muri” e questa sua determinazione e disciplina sono forse la ragione della sua lunga latitanza.
Moretti dice che le Br non sono un partito, ma un avanguardia, una concezione leninista della lotta, che secondo loro nasceva da una esigenza della classe operaia, qui già anticipa i suoi primi dubbi sulla loro analisi della società che stavano vivendo. Ma i dubbi non ci sono perché l’intera società che lo circonda sembra di vederla come lui e perché “per sua fortuna non ha letto abbastanza per averne”. La guerriglia urbana si ispira ai tupamaros, che ha come icona Che Guevara, mentre l’esigenza della lotta armata, per alcuni estremisti della sinistra rivoluzionaria, nasce con lo scoppio della bomba di piazza fontana perché nell’aria c’è un pericolo “oscuro di cui si percepisce soltanto la potenza”. Moretti dice che i comunisti come lui hanno sentito che si stava marciando verso la sconfitta e che la lotta armata, giustificata da una forte autoreferenzialità, è stato un tentativo per deviare questo corso ma la disfatta avanza primo per ”l’incapacità di articolare una strategia che regga nel tempo”, poi per la “sinergia fra il processo di ristrutturazione capitalistica e la cooperazione nello stato di tutto quello che era stata la rappresentanza proletaria storica”. Ma questa è un analisi postuma perché Moretti afferma che, ad eccezione di pochi, non se ne sono mai accorti.
Le prime colonne nascono da una decina di membri e si sviluppano a Torino e Milano, poi Genova e il Veneto nel distretto industriale di Marghera. Moretti racconta il primo sequestro di rilievo quello del magistrato Sossi a cui egli non partecipa direttamente, quindi descrive l’arresto di Curcio e Franceschini. L’infiltrato Girotto “frate mitra” fa arrestare a Pinerolo i due capi delle Br nonostante qualcuno faccia sapere ai brigatisti della retata; Moretti lo viene a sapere la sera prima, tuttavia Franceschini accusa, ma mai apertamente, che Moretti non ha fatto abbastanza per impedire il loro arresto. Moretti invece ritiene di aver fatto tutto il possibile o tutto quello che riteneva il possibile per impedire l’arresto di Curcio. Moretti infatti sostiene che non sapesse che Franceschini fosse con Curcio, sarebbe dovuto stare a Roma. Moretti ricorda una notte insonne, da Milano a Parma per raggiungere il rifugio di Curcio, poi trovato vuoto, quindi sulla strada per Pinarolo appostato con un altro compagno su due strade diverse, scopre solo dopo quando raggiunge la Cagol alla cascina Spiotta che Franceschini è con Curcio. Moretti si sente la coscienza più che pulita difronte alle accuse di Franceschini che da parte sua non ha mai spiegato invece perché non era andato a Roma.
Il triennio ‘74 / ‘76 vede azioni importanti delle Br come l’omicidio del magistrato Coco, un atto di guerra per Moretti, ed il sequestro del giovane Costa che frutta alle Br tanti soldi sufficienti per garantire gli stipendi dei brigatisti fino al 1981. I brigatisti, giura Moretti, prendevano la paga di un operaio, circa 200000 lire ed il salario era uguale per tutti. Nel febbraio 1975 c’è la liberazione di Curcio con un commando guidato dalla Cagol dal carcere di Monferrato ma anche, nei mesi successivi, la morte in uno scontro a fuoco della stessa Mara Cagol e alla fine del ‘76 di quella del giovane Walter Alesia sempre in uno scontro a fuoco, entrambe forse evitabili secondo Moretti se le cose fossero state gestite diversamente. Poi ancora l’arresto di Curcio che sente la sua linea perdere peso nell’organizzazione mentre avanza quella più militarista di Moretti. Moretti ricorda l’affiatamento politico con la Cagol ed il rispetto con Curcio. Le Br si espandono in varie città d’Italia, nel 1975 scendono a Roma ma non andranno mai al Sud. I brigatisti clandestini sono al massimo una decina per colonna, molti di più gli irregolari che li appoggiano, alla fine saranno centinaia i brigatisti in carcere e pochi fuori. Nel ‘77 molti giovani inneggiano alle Br mentre il PCI esce da un momento d’oro a livello di consenso elettorale, ma Moretti non riesce a chiedere a questi ragazzi altro che entrare nelle Br mentre Berlinguer, preoccupato che l’Italia faccia la fine del Cile, spinge sempre di più verso il compromesso storico.
Arriva il ‘78, un affollata direzione nazionale delle Br, probabilmente una quindicina di brigatisti da tutta Italia, decide di dare via al sequestro Moro “il gran sacerdote che per far tornare i conti del potere è capace di fondare un’eresia” dopo aver scartato per motivi logistici quello di Andreotti “il giocoliere che alla fine dei maneggi fa sparire il mazzo di carte”.
Moretti ci dice che la scelta del 16 marzo, che coincide con il giorno della votazione del quarto governo Andreotti con il sostegno esterno del PCI, è casuale, l’azione è stata prevista da prima. Alcune sue dichiarazioni risultano anche come delle rivelazioni: Moro non è mai stato in via Gradoli dove invece viveva lui e la Balzerani, Moro è stato sempre in Via Montalcini 8, non c’è mai stata nessuna moto Honda come componente del gruppo di fuoco di via Fani, le Br non erano così addestrate e armate come si è creduto, molti colpi sono andati a vuoto, una mitragliatrice si è inceppata, piuttosto la scorta di Moro era impreparata, la mitragliatrice dei poliziotti era nel baule e da parte delle Br c’è stato uno scrupoloso piano di azione elaborato in cinque mesi ed una ferrea autodisciplina. Moretti non ha partecipato al gruppo di fuoco che ha sparato alla scorta, era alla guida della 128 che ha bloccato il corteo delle auto del presidente Moro ma non si è fatto tamponare come si è creduto, Moretti sostiene che l’autista dell’auto della scorta, ferito, ha cercato un disperato tentativo di fuggire colpendo però la FIAT 128 con targa consolare guidata da Moretti. È stato Moretti a prelevare Moro dall’auto per metterlo su di un altra auto, quindi dentro una cassa per poi passare su due mezzi diversi e finire in via Montalcini 8, l’appartamento è intestato alla Braghetti e con lei vive un “compagno” Altobelli che non è mai stato individuato dalla polizia e che Moretti non rivela. Durante il sequestro, il brigatista Gallinari resterà sempre dentro l’appartamento senza uscire mentre Moretti farà da spola tra questa base ed il Comitato Esecutivo delle Br in orari dove è difficile notarlo. Moro viene interrogato e Moretti ammette la sua ignoranza nella conoscenza del potere e della sua gestione, persino alcune confidenze di Moro sono sottovalutate e comprese da Moretti solo a posteriori, Moretti “conversa” con Moro sempre indossando un passamontagna. Da fuori arriva la mazzata del PCI che abbraccia la linea della fermezza, Moro tuttavia è convinto che la prima mossa per la sua liberazione la debba fare la DC, ma Moro, altra nota di rilievo fatta da Moretti, pensa che il suo partito sia stato narcotizzato, che elementi appartenenti alla Nato abbiano potuto interferire. Moro passava il suo tempo a scrivere e a pregare. Moro cerca di salvarsi, di gestire lo scontro sociale arrivato a questo punto in altra maniera, fa appelli a tutti ma quando anche il papa lo abbandona intuisce di essere perduto, tuttavia scrive una seconda lettera al papa perché forse capisce che le Br vogliono solo essere prese in considerazione, Moretti dice che se qualcuno avesse detto “Fermi, discutiamone” loro si sarebbero fermati. Le Br quindi ad eccezione di Morucci e Faranda si pronunciano per la condanna a morte di Moro, anche i brigatisti in carcere si allineano. Moro fa rivelazioni importanti ma i brigatisti non sono interessati a queste, solo ora Moretti se ne accorge, per esempio le informazioni su Gladio. Il presidente della DC quindi cerca di convincere i suoi carcerieri ma ottiene solo il tentativo disperato delle Br di chiamare la famiglia Moro per chiedere che la DC faccia qualche autorevole dichiarazione di dialogo che però non verrà mai, a fare la chiamata sarà Moretti.
Moro, secondo Moretti, è consapevole che verrà ucciso, non sa dove e quando, gli viene detto di salire in auto per uscire e Moretti spara nove colpi con due armi diverse, questa è un’altra rivelazione del libro, non è stato dunque Gallinari a premere il grilletto, Moretti pensando al peso del suo omicidio e a Moro dice di sentirsi “in pace con quell’uomo”.
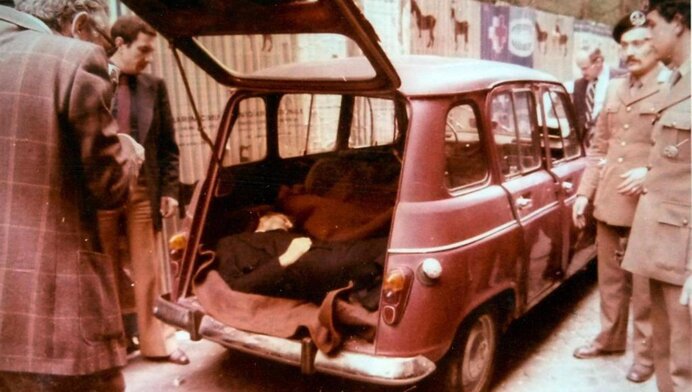
Le ragioni politiche della morte di Moro sono numerose, le Br lo uccidono perché il PCI sta andando lontano dalla rivoluzione comunista, le Br lo uccidono perché il PCI non ha fatto nulla, non ha detto nulla per fermarli. “Sarebbe andata diversamente se si fosse spezzato il fronte della fermezza” sostiene Moretti. Moretti ritiene che alla fine degli anni ‘70 l’unica opposizione sono i comunisti combattenti, la svolta del PCI e il compromesso storico, che “neppure Berlinguer lo previde”, ha “consegnato ai gruppi forti della borghesia i poteri istituzionali”. Anche se la lotta armata non da i frutti sperati Moretti la giustifica per la persistenza di una “miseria sociale e umana”. Lo slogan passa da “colpirne uno per educarne cento” a “colpire dovunque i centri della controrivoluzione”.
Dal libro emerge anche un’altra rivelazione. Quanti sono stati i brigatisti? Secondo Moretti il numero dei brigatisti regolari è pari agli arrestati, mentre quello degli irregolari va moltiplicato per 10. Allora facciamo i conti prendendo come riferimento uno studio (“progetto memoria”) fatto da Curcio secondo il quale il numero degli inquisiti è stato di 1337, siamo quindi ad una nuvola di circa 10 mila brigatisti.
Dal 1978 in poi Moretti, su incarico della direzione delle Br, intrattiene rapporti con altre organizzazioni terroristiche di altri paesi come l’Eta, la Raf, l’Olp. Viaggiava in aereo quattro volte alla settimana tra Roma e Parigi, lui il terrorista più ricercato d’Italia, grazie a documenti ben contraffatti e un po' di pazzia. Moretti ancora smentisce contatti delle Br con servizi segreti stranieri: “Si può dire di noi di tutto, fuorché che siamo stati qualcosa di poco limpido.” In Italia dopo Moro lo scontro con il PCI si fa più duro e a Genova a rimetterci la vita è Guido Rossa, anche contro le forze dell’ordine la guerriglia diventa più sanguinaria e bersaglio delle Br diventa la Digos. Moretti racconta anche il tentativo di aver provato a far evadere i compagni dal carcere dell’Asinara e di come non siano riusciti a metterlo in pratica. Iniziano quindi i primi momenti di crisi interna per arrivare al tradimento di Peci (inaspettato anche se prevedibile che prima o poi qualcuno avrebbe parlato). Le informazione che Peci da a Dalla Chiesa fanno dare un duro colpo alle Br, la colonna genovese viene massacrata in via Fracchia dalle forze speciali dei carabinieri che “li uccidono deliberatamente, tutti.”
Dopo l’arresto le Br, già rimaste in “quattro gatti”, fanno alcune azioni, tra cui il sequestro di Cirillo. In carcere Moretti passa i primi mesi a leggere Tolstoj, quindi sventa un tentativo di omicidio da parte di un camorrista che lo accoltella più volte prima di essere fermato da un compagno di Moretti e portato via dalle guardie carcerarie. Moretti non sa chi è il mandante ma da la colpa ai carabinieri “che va sempre bene”. Dopo l’accoltellamento Moretti viene trasferito a Cuneo dove incontra e dialoga con Franceschini, Curcio lo rivedrà solo nel 1986. Intanto le Br fuori dal carcere iniziano a litigare fra loro “una virgola diventa un monumento, una parola diventa un macigno.” Moretti nella spaccatura delle Br non si schiera con nessuno e per questo è l’unico che parla con tutti. Mentre le Br fuori si dividono in un “arcipelago” emerge la linea dura di Senzani, che è una risposta ad uno stato sempre più aggressivo e violento nei confronti dei brigatisti, linea che Moretti ritiene “demenziale”, l’uccisione dei delatori (Moretti ritiene che la delazione sia un fenomeno inevitabile per quanto spiacevole in fasi di guerriglia) o di collaboratori come Roberto Peci, fratello del pentito, vengono considerate una “follia”. La legislazione muta e la delazione “assume carattere politico”. “Non ci sono più colpevoli e innocenti, ma delatori reo confessi oppure irriducibili”. Su Peci Moretti dice che nessuno se lo aspettava e aggiunge “al tradimento ci si arriva perché si sente la sconfitta”. Poi racconta anche di chi ha resistito alle torture come Maurizio Ianelli che per non cedere dopo tre giorni di torture in Questura si è buttato su una vetrata recidendosi i polsi e quindi tolto dall’isolamento. Con il governo Spadolini viene introdotta la tortura. Iniziano anche i primi dissociati, ovvero chi senza pentirsi rinnega la lotta armata. È il 1987, Moretti ed altri arrivano anche loro a deporre le armi, per essi però non è un dissociarsi ma una resa, l’ammettere di essere stati sconfitti. E di certo l’ultima parola del libro non è un caso:”sconfitta.”
di Francesco Filippi
©